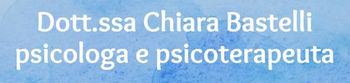Leggi tutti gli articoli pubblicati dalla Dottoressa Chiara Bastelli
Tutti gli articoli pubblicati sono disponibili anche nel mio blog personale.
Visitalo per leggerli e lasciami le tue impressioni.

Titolo diapositiva
Scrivi qui la tua didascaliaPulsante
"L'amore ai tre vertici di un triangolo" di Chiara Bastelli
Da sempre l’uomo si interroga sull’amore, sulla sua natura e sulle sue implicazioni: cosa succede alla nostra mente quando ci innamoriamo o quando la passione finisce? In merito sono state formulate molte teorie, e lo psicologo statunitense Robert Sternberg, noto per aver elaborato un modello tripartitico dell' intelligenza, ne ha ideata una sull'amore che ha suscitato molto interesse: “la teoria del triangolo”.
Secondo Sternberg l’amore è il risultato di tre componenti, che si possono idealmente collocare ai vertici di un triangolo: intimità, passione e decisione-impegno.
L’intimità è il sentimento di affinità che si stabilisce tra i due amanti, quel comune sentire che li porta a voler condividere quasi tutto e a considerare il loro rapporto come l’esperienza più importante che stanno vivendo. È il momento in cui due persone si conosco: l’intimità nasce attraverso l’autorivelazione e porta i due partner a volersi esplorare e a prendersi cura l’uno dell’altro.
La passione riguarda gli impulsi più profondi e carnali, come l’attrazione fisica, il desiderio sessuale, di appartenenza, ma anche di dominio o di sottomissione.
La passione è un importante termometro della relazione perché da essa scaturiscono sia i sentimenti positivi come l’appagamento e l’entusiasmo,
quanto quelli negativi come la gelosia e l’autodistruzione, ed è inoltre la prima a incrinarsi quando qualcosa nel rapporto non funziona più.
La componente decisione-impegno consiste nella scelta di amare qualcuno e nell’impegno a mantenere nel tempo una relazione. Stare assieme a una persona comporta decisioni, cambiamenti e sforzo: ci vuole anche una certa razionalità nel convincersi di evolvere assieme, di superare le crisi e gli ostacoli in nome di una progettualità condivisa.
Dalla combinazione di queste tre componenti Sternberg individua dunque sette tipi o forme di amore, variamente rappresentati nelle relazioni di tutti i giorni.
1) Simpatia (solo intimità). È la relazione dell’amicizia, nella quale vi è confidenza, un senso di intimità, ma mancano le caratteristiche della passione e dell’impegno.
2) Infatuazione (sono passione). È un rapporto breve basato sull’intesa sessuale che sfiorisce quando viene meno la fase di forte desiderio erotico. È tipico dell’amore a prima vista, che si sviluppa improvvisamente e che si basa di solito più sull’idealizzazione dell’altro che su una reale conoscenza.
3) Amore vuoto (solo decisione-impegno). È presente in alcune relazioni lunghe quando, per il bene dei figli, paura di rimanere soli o semplici considerazioni economiche, si tiene in piedi una relazione ormai finita, nella quale mancano intimità e passione.
4) Amore romantico (intimità più passione). È l’amore idealizzato dai romanzi e dai film, ma nella realtà rappresenta un amore che non riesce a sbocciare, perché manca
della componente dell’impegno, assente a causa dell’impossibilità di progettare un futuro assieme.
5) Amore-amicizia (intimità più decisione/impegno). Si riscontra in quei rapporti di lungo corso, quando persiste l’intimità e la volontà di affrontare progetti comuni, ma ormai la passione è scemata.
6) Amore fatuo (passione più decisione/impegno). In questa relazione l’impegno è conseguenza della passione senza una vera conoscenza reciproca. Sono, ad esempio, i matrimoni improvvisi, decisi in maniera impulsiva sull’onda dell’infatuazione. Le criticità maggiori vengono in luce però quando la coppia si trova a fare i conti con un impegno non condiviso o sentito.
7) Amore “perfetto” (intimità più passione più decisione/impegno). Questo è l’amore completo e totale che tutti sognano: non è impossibile farne un’esperienza reale, ma è difficile mantenerne vive le caratteristiche nel tempo.
Secondo Sternberg per mantenere l’amore “perfetto” è necessario che tutte e tre le componenti siano alimentate e curate nel tempo. Complicità, passione e fedeltà agli impegni sono elementi di un equilibrio delicato che va mantenuto con impegno e attenzione; il raggiungimento di questo equilibrio non può essere considerato come un traguardo, ma come un compito da perseguire, con costanza e ardore, giorno dopo giorno.

Titolo diapositiva
Scrivi qui la tua didascaliaPulsante
"Discussioni fra colleghi: gli errori da evitare per non soccombere" di Chiara Bastelli
Trascorriamo buona parte della nostra giornata sul luogo di lavoro, e i rapporti con i colleghi non riescono a essere sempre sereni e proficui come vorremmo. Ogni giorno viviamo situazioni di tensione più o meno accentuate che possono sfociare in veri e propri litigi. Eppure, non sempre le discussioni sono negative: alle volte possono essere l’occasione per chiarire disagi e incomprensioni, e favorire un nuovo flusso della comunicazione.
Nella maggior parte delle occasioni, però, litigare con i colleghi ha come unico effetto quello di renderci nervosi, e insinuare dubbi sulle nostre capacità. Essere costretti a sopportare un’atmosfera tesa può rendere le nostre giornate infinite.
Poiché a chiunque di noi capiterà, prima o poi, di affrontare un litigio, è bene imparare, nei limiti del possibile, a gestirlo. Quante volte ci succede di ripensare alle discussioni avute e, a mente fredda, trovare finalmente le frasi giuste e ad effetto che però ormai è tardi per dire? Quante volte, invece, abbiamo reagito in maniera scomposta facendo affermazioni delle quali poi ci siamo pentiti?
Imparare a gestire un litigio significa proprio questo: essere in grado, quando la discussione divamperà, di comportarci con razionalità, scegliere le parole giuste e affrontare argomenti che possano rivelarsi utili a una buona convivenza.
Per prima cosa dobbiamo renderci conto che evitare i litigi non è sempre la scelta più saggia.
Sopportare situazioni che non ci vanno bene, nel nome del “quieto vivere”, rischia di farci poi “esplodere” nel momento meno opportuno o, al contrario, di farci
somatizzare il disagio, ritrovandoci in compagnia di un malessere costante che non ci abbandona neanche quando usciamo dall’ufficio.
Quando si “decide” di litigare – o, più semplicemente, di confrontarsi – è bene essere diretti e pertinenti: è meglio evitare accuse troppo vaghe o allusioni generiche su un comportamento a nostro avviso inappropriato, del quale non specifichiamo però i confini: «Ne avrei di cose da dire su di te, ma non è il caso».
Con affermazioni di questo tipo non otteniamo nulla, se non un progressivo accrescersi del rancore che proverà l’interlocutore nei nostri confronti.
Allo stesso modo, le accuse che esulano dalla sfera professionale sono dannose, oltre che di cattivo gusto. Tirare in ballo la vita privata del nostro collega, o vecchi episodi e confidenze, non ci aiuterà a risolvere il problema che abbiamo con lui, ma, al contrario, servirà solo a renderlo maldisposto nei nostri confronti.
Per evitare fraintendimenti, dunque, è consigliabile prima di tutto avere chiaro quali sono gli elementi che ci mettono a disagio. Riflettere su ciò che non funziona ci aiuterà anche a capire quali colpe sono effettivamente imputabili al nostro collega e quali invece vanno ricondotte all’ambiente, a un errato flusso del lavoro o addirittura a noi stessi.
Quando sentiamo che è giunto il momento di confrontarci, dunque, ricordiamo di tenere un tono di voce pacato e di parlare con sincerità.
Secondo Paul Watzlawick «ogni comunicazione ha un aspetto di contenuto e uno di relazione» e l’interlocutore spesso coglie, anche inconsciamente, un’eventuale incongruenza fra ciò che diciamo e ciò che invece esprimiamo, senza rendercene conto, con il corpo: la postura, gli ammiccamenti e l’espressione dello sguardo a volte rivelano ben più di quanto facciano le nostre parole.
È quindi consigliabile portare alla luce ciò che ci disturba, ma senza lanciare accuse: nessuno potrà contestare il fatto, ad esempio, che «mi sono sentito sovraccaricato di
responsabilità», mentre non porterà a nulla dire: «Non ti occupi mai delle pratiche più delicate».
Allo stesso modo, dobbiamo fare attenzione che la nostra critica sia sempre rivolta alla prestazione, e mai all’identità dell’interlocutore. Anche se a volte si rischia di fare confusione, criticare la prestazione («Il lavoro non è fatto nella maniera corretta») è accettabile, mentre contestare il valore della persona («Non sai lavorare») non porterà a niente di proficuo.
Come reagire, invece, alle offese verbali e scomposte dei colleghi? In questo caso ognuno segue la propria indole: c’è chi ostenta indifferenza, chi subisce passivamente e chi reagisce con veemenza. Se alle volte il semplice silenzio si rivela un’arma efficace, in altri casi può venirci in soccorso la disciplina zen.
L’aikido verbale richiama l’omonima arte marziale che prevede di salvarsi da un attacco senza danneggiare colui che ce l’ha portato.L’argomento meriterebbe una riflessione più approfondita, ma esiste una storia che forse può insegnarci qualcosa.
Un uomo, infastidito dalla reputazione del Buddha, lo accusò di essere solo un supponente, un impostore e di non avere diritto di dare consigli ad altri.
Mentre ascoltava gli insulti che l’uomo gli rivolgeva, il Buddha rimase immobile. Solo quando l’attacco perse di intensità, gli disse: «Posso farti una domanda?»
L’uomo, disorientato, acconsentì: «Cosa?» concesse.
«Se qualcuno ti offre un dono e tu lo declini, a chi appartiene quel dono?»
L’uomo ci pensò, poi disse: «Beh, appartiene alla persona che l’ha offerto».
«Lo stesso vale per l’invidia, la rabbia e gli insulti» disse il maestro. «Quando non sono accettati, continuano ad appartenere a chi li portava con sé».

Titolo diapositiva
Scrivi qui la tua didascaliaPulsante
"I compiti più difficili" di Chiara Bastelli
In questi giorni d'estate si vede rimbalzare, su internet e i social network, l’anomala lista dei compiti per le vacanze che un insegnante di Fermo ha consegnato ai suoi alunni del liceo. Fra gli inaspettati impegni che spetteranno ai ragazzi si legge: «Ballate senza vergogna e sognate la vostra vita. Non dite parolacce e siate sempre gentili. Almeno una volta, andate a vedere l’alba». E ancora: «Leggete e sognate il vostro futuro. Se vi sentite tristi o spaventati, non vi preoccupate: l’estate, come tutte le cose meravigliose, mette in subbuglio l’anima».
L’idea del professore ha stupito, affascinato e fatto discutere. La polemica sulla mole dei compiti per le vacanze sboccia ogni anno con la bella stagione, e già in marzo il ministro del lavoro
Giuliano Poletti aveva suggerito di riempire la pausa estiva dei ragazzi con esperienze di lavoro e formative. Non tutti, però, sono d’accordo. Ci sono infatti psicologi come Teresa Belton, studiosa dei problemi dell’infanzia e dell’apprendimento, che tesse un vero e proprio elogio dell’ozio. Se anche a settembre i ragazzi daranno l’impressione di “aver dimenticato tutto”, gli insegnanti non potranno ignorare i cambiamenti avvenuti nei loro alunni: li troveranno cresciuti, non solo fisicamente, e maturati. Questa evoluzione, che si ripropone all’inizio di ogni nuovo anno scolastico, è però frutto anche di quel periodo transitorio, fatto di momenti di svago, di confronto con coetanei e genitori, e talvolta persino di vuoto.
In fondo, i ritmi così accelerati della routine quotidiana – tra lezioni, compiti, sport e vita associativa – eliminano proprio quelle situazioni d’ozio che sono invece utili per lo sviluppo della fantasia, della capacità di autogestirsi e di maturare personalità indipendenti. Lontani dagli impegni stabiliti i ragazzi hanno l’occasione per riflettere, sognare, conoscersi
meglio, interrogarsi su se stessi e sul proprio futuro.
Per i bambini, inoltre, il periodo delle vacanze è ancora più importante. Lo sviluppo dell’identità è condizionato, nei primi anni di vita, dall’identificazione con i modelli che si trovano in famiglia. Così, affrontare un viaggio – che si tratti di un’avventura all’altro capo del mondo o una semplice gita fuori porta – si trasforma per loro nella possibilità di incentivare la propria curiosità e la fantasia, ma non solo: condividere l’uscita degli spazi familiari in compagnia dei propri modelli di riferimento rafforza in loro la sicurezza nell’esplorare situazioni nuove. Sempre che, naturalmente, i genitori siano in grado di infondere fiducia e serenità ai figli anche di fronte ai problemi e agli imprevisti che si verificano durante qualsiasi viaggio.
Come spesso accade, dunque, anche d’estate i compiti più difficili sono quelli che spettano ai genitori. Buone vacanze, buone gite e buona noia a tutti.

Titolo diapositiva
Scrivi qui la tua didascaliaPulsante
"La ricerca della felicità (a tutti i costi)" di Chiara Bastelli
Il rientro dalle vacanze è un momento difficile per tutti, ma pare esserlo in particolar modo per le coppie. Lo sanno bene gli avvocati divorzisti che nei mesi di settembre e ottobre si trovano a dover fronteggiare un picco nelle richieste di separazione.
La convivenza forzata in villeggiatura e i ritmi più rilassati dell’estate, infatti, spesso lasciano emergere i problemi che durante l’inverno erano stati sottovalutati, o imputati allo stress e ai troppi impegni. Con l’arrivo della bella stagione, dunque, nelle riviste di attualità assistiamo a un proliferare di articoli prodighi di consigli su come non incrinare il rapporto di coppia.
Spesso ci accontentiamo di queste soluzioni “pronte per l’uso” invece di ricercare nell’esperienza unica e irripetibile della nostra coppia le informazioni che ci permettano di vivere appieno la nostra relazione, di gratificare noi stessi e il partner.
In questa epoca di grande attenzione verso il proprio individualistico benessere, di ricerca della felicità a tutti i costi, si nasconde “quell’inconscio timore di amare” che per E. Fromm è più forte del timore di non essere amati.
In questo, e in molti altri casi, le neuroscienze ci possono aiutare più delle riviste generaliste. Il professor Giacomo Rizzolatti, dell’Università di Parma, è stato il primo a individuare il funzionamento dei “neuroni specchio”: se annusiamo un odore sgradevole, la nostra espressione disgustata provocherà nell’individuo che in quel momento ci osserva, proprio grazie ai “neuroni specchio”, l’attivazione della stessa area del cervello, anche se non ha sperimentato in prima persona la sgradevolezza
della sensazione olfattiva.
Ecco dunque spiegato perché un sorriso o uno sbadiglio sono contagiosi, ma anche perché frequentare persone divertenti ci infonde allegria.
Se volessimo utilizzare per la coppia i suggerimenti che ci derivano dalle neuroscienze, potremmo riassumere tutto in un unico, semplice proposito: fai all’altro ciò che vorresti fosse fatto a te.
Sorridiamo, quindi, siamo propositivi, ascoltiamo e guardiamo l’altro senza smettere di chiederci: “Cosa posso fare per rendere più serena questa vacanza?”.
La nostra felicità influenzerà quella del partner che, a sua volta, avrà un effetto benefico su di noi.
Nella maggior parte dei casi, lo sforzo vale il risultato.

Titolo diapositiva
Scrivi qui la tua didascaliaPulsante
"Selfie e Sexting: Rituali e simboli di una società alla ricerca di conferme" di Chiara Bastelli
Un ragazzo indiano di ventiquattro anni ha da poco abbandonato il proprio lavoro perché vuole entrare nel guinness dei primati. Il suo obiettivo? Battere il record mondiale di selfie in un’ora.
Un uomo ruba il telefonino a un turista, poi non resiste alla tentazione e si fa un selfie. A causa delle impostazioni dell’apparecchio, però, l’immagine finisce subito in rete e il ladro viene presto riconosciuto.
A Collette Moreno, 26 anni, e Courtney Anna Sanford, 32, un selfie scattato mentre erano alla guida è costato la vita. Un’indagine Ford su 7000 giovani automobilisti europei dimostra che il 25% di loro non resiste alla tentazione di farsi un autoscatto al volante.
Un pilota di caccia danese si è spinto ancora oltre: a bordo di un F-16, ha scattato una foto mentre faceva partire un missile e l’ha pubblicata sui social network. Appena la notizia si è diffusa, l’esercito l’ha spinto a congedarsi.
Charlotte Michaels, studentessa ventitreenne, si scatta oltre duecento selfie al giorno, ed è “costretta” a rinunciare alla sua vita sociale in modo da avere il tempo per scegliere la location più adatta, gli outfit e le espressioni più accattivanti, oltre che per editare le foto.
Il selfie, ormai è risaputo, consiste nel farsi un autoscatto e postarlo sui social network, ed è diventato più di una semplice moda. Anzi, si può dire che sia rituale e simbolo di una società – non solo di una generazione –, anche se non manca di suscitare qualche apprensione fra psicologi e sociologi.
Lo psicoanalista Michel Stora ha rilevato: «Siamo passati da una società inibita e piena di segreti a una società esibizionista». Questo esibizionismo, però, potrebbe nascondere un altro tipo di disagio: non riuscendo a trovare un’identità forte, la nostra generazione si affiderebbe alla superficie.I selfie contengono una componente narcisistica che va presa in considerazione e analizzata, perché potrebbe rivelare una necessità più profonda di essere riconosciuti e apprezzati.
«L’immagine diventa il biglietto da visita, la propria autodefinizione» ha dichiarato lo psichiatra Vittorino Andreoli. «La nostra identità si è dispersa in frammenti, e la definiamo ogni volta che schiacciamo un pulsante».
Così nei selfie immortaliamo la nostra vita, i viaggi, gli hobby e il look. Allo stesso modo, il sexting (pubblicare autoscatti in pose sexy e atteggiamenti provocanti) serve a esprimere la nostra identità di genere, ma anche e soprattutto ad attirare consensi, brevi gratificazioni che ci fanno sentire vivi.
Ciò che muove il “fotografo” non è più l’interesse per l’immagine, quanto piuttosto la possibilità di condividerla sui social network. Il primo autoscatto, d’altronde, è del 1840, ma solo negli ultimi anni abbiamo l’opportunità di ribatterli su facebook, snapchat, instagram o simili, e monitorare le reazioni dei nostri amici.
Il selfie è un momento di onnipotenza durante il quale attore e regista coincidono, e ogni fotografia è una richiesta di attenzione, un termometro che serve a misurare gli interessi degli altri nei nostri confronti, i loro giudizi, i loro “like”.
In questo modo, chi si fotografa intende porsi, più o meno consapevolmente, come oggetto dei commenti, alla ricerca di apprezzamenti e conferme che probabilmente fatica a trovare altrove.
Scrive lo psicologo Edoardo Giusti: «A livello psicobiologico questo “like” è un tiramisù, somministra
ossitocina digitale. Abbassa stress e ansia. Compensa la mancanza di autostima, di sicurezza. Esorcizza l’incubo dell’invisibilità. Alla fine, privilegiano la quantità più che la qualità. Conta il numero degli “amici” che hai e quello delle visualizzazioni. Se non puoi dimostrare di esistere, non esisti».
Dello stesso avviso è Paolo Chiari, segretario scientifico del Centro milanese di psicanalisi: «Il selfie testimonia un esserci che non è realmente sentito: una conferma di esistere che viene rimbalzata attraverso dei mezzi, apparentemente di “comunicazione”, ma che in realtà restano in superficie e non permettono di creare vere relazioni». Si tratta di una condizione «molto adolescenziale, comprensibile in questa epoca della vita in cui è necessario rompere con l’immagine di sé trasmessa dai genitori e in cui si cerca una nuova identità. Il problema è che oggi riguarda molto anche gli adulti. Siamo una società di adolescenti».
Una condizione che non è priva di insidie: al narcisista manca la capacità di cooperare, di stare e lavorare insieme. Ha bisogno solo di primeggiare e, allo stesso tempo, vive nel terrore di essere dimenticato. La prova della sua esistenza è nei post e nei selfie, per questo motivo non riesce più a smettere.
Per avere la certezza di non essere passati su questo mondo invano, ci ostiniamo dunque a rimirare noi stessi in selfie che dovrebbero darci una conferma della nostra esistenza, ma che finiscono per confondersi dopo pochi istanti in mezzo a milioni di altri volti – sorridenti, imbronciati, provocanti – tutti troppo anonimi e uguali per lasciare davvero un segno.

Titolo diapositiva
Scrivi qui la tua didascaliaPulsante
"L' EMDR e il suo utilizzo nel caso di lutto traumatico"di Chiara Bastelli
Domenica è valsa la pena di alzarsi all’alba e scivolare nelle brume di una Milano ormai avvolta da un’affascinante atmosfera autunnale, perché ad attendermi c’era una giornata di approfondimento organizzata dall’Associazione per l’EMDR in Italia.
EMDR è un acronimo inglese che sta per “Desensibilizzazione e rielaborazione attraverso movimenti oculari” ed è un metodo psicoterapico che facilita il trattamento di problematiche legate a eventi traumatici o esperienze stressanti. Attraverso una serie di stimolazioni oculari bilaterali alternate si può procedere alla desensibilizzazione del ricordo e quindi all’elaborazione di eventi traumatici disturbanti.
A condurre l’incontro c’era il dott. Roger Solomon, esperto in ambito internazionale, che si è concentrato in particolar modo sul lutto traumatico. Superare un lutto significa accettare la perdita del proprio caro, ma questo non è sempre possibile.
Le reazioni alla perdita di una persona amata, soprattutto se il decesso è avvenuto in modo fulmineo, senza preavviso (infarto, ictus, incidente, catastrofe naturale…) o è stato causato volontariamente dall’uomo (omicidio, suicidio, strage…) sono di tipo soggettivo e non generalizzabili. Il tempo per l’elaborazione può variare da pochi mesi a un anno, un anno e mezzo; il dolore può decrescere lentamente nel tempo e poi riattivarsi in occasione di una ricorrenza (ad esempio le festività natalizie) oppure un anniversario. Il lutto comporta il vivere ed esperire le proprie reazioni alla perdita. L’elaborazione del lutto rappresenta il nostro adattamento alla perdita.
Si parla dunque di “lutto traumatico” quando la rappresentazione interiore adattiva della persona defunta è ostacolata da pensieri che causano disagio, come nelle relazioni complicate da rabbia, ambivalenze affettive, abusi…
Per riuscire ad adattarsi all’evento luttuoso e andare avanti nel proprio cammino accettando la perdita, occorre dunque elaborare i traumi, i conflitti e i ricordi negativi del proprio passato.
Nel caso di un lutto complicato o di un lutto traumatico l’EMDR pare essere una tecnica particolarmente indicata per facilitare i processi naturali di elaborazione. Agendo sui ricordi e sui significati collegati
agli stessi, si permette infatti alla persona di andare avanti nella vita in modo più consapevole.
Gli studi di efficacia condotti sull’EMDR sono effettuati con costante riferimento alle neuroscienze e alla ricerca dei substrati neurofisiologici in grado di spiegare quello che avviene nel cervello di una persona durante il processo terapeutico. L’EMDR si rivela quindi efficace nella rielaborazione dello stress post-traumatico perché attiva il processo naturale omeostatico di elaborazione dell’informazione.
A questo proposito è importante citare il dott. Marco Pagani del CNR di Roma, che ha condotto una ricerca molto interessante sulle modalità di elaborazione di un evento traumatico, rilevando che “in seguito all’elaborazione di un evento traumatico, aree specifiche del sistema limbico rinforzano le connessioni con la corteccia associativa, dimostrando uno spostamento, dopo la terapia EMDR, delle attivazioni corticali da aree cerebrali a prevalente elaborazione emozionale a quelle a prevalente elaborazione cognitiva” (tratto da: “Report dal congresso nazionale EMDR, 8-10 novembre 2013).
Si conferma dunque la validità dell’EMDR, praticato da uno psicoterapeuta esperto, anche nel lavoro sul lutto traumatico.